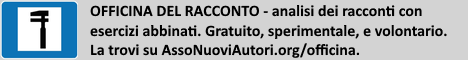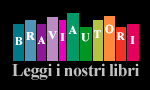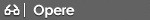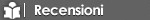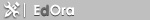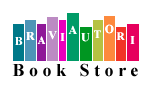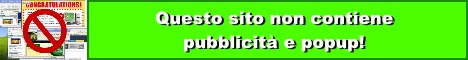Sarà molto bello
Sarà molto bello
-
Ivo Aragno
- rank (info):
- Foglio bianco
- Messaggi: 39
- Iscritto il: 29/10/2024, 9:59
-
Author's data
Commento
-
Vittorio Felugo
- rank (info):
- Pubblicista
- Messaggi: 77
- Iscritto il: 05/10/2023, 11:52
-
Author's data
Commento
Mi è piaciuto, complimenti!
Commento
Un componimento tra prosa e poesia fatto di vari frammenti (6) sulla scia della memoria. Lirico essenzialmente: essendo poetico. È un testo che trasmette calma.
Ma questo passaggio qui:
"Ma sono certo che quell'esperienza di pace è accessibile a tutti. E che tutti ci si possa fondere assieme, in quella specie di minestra tiepida dove viviamo."
Ricorda concetti di Averroè: nel senso di anima unica, e non personale, e condivisione. Visto nel tuo testo come una sorta di invito a riconoscere la nostra comune umanità e a cercare la pace e l'armonia tra di noi.
Bravo!
Saluti…
Antonio
Voto: 4
Ho letto male io, scusa. Nessun refuso, ma a volte nel testo c'è qualche spazio in più. Capitano!
Scrivo direttamente qui i commenti e posso sbagliare!
Avendo il notebook che non funziona più bene.
Re: Commento
Hai centrato ! Era quello che desideravo comunicare. Non una esercitazione di scrittura, ma, come dire ? Un manifesto. Una esortazione a cercarla quella pace. A fonderci assieme, rinunciando ad un po' a individualismi, a dire: "no, grazie" alla solitudine dell'io.Yakamoz ha scritto: 20/01/2025, 12:13 Ciao, Bobinsy, (prima volta che ti commento)
Un componimento tra prosa e poesia fatto di vari frammenti (6) sulla scia della memoria. Lirico essenzialmente: essendo poetico. È un testo che trasmette calma.
Ma questo passaggio qui:
"Ma sono certo che quell'esperienza di pace è accessibile a tutti. E che tutti ci si possa fondere assieme, in quella specie di minestra tiepida dove viviamo."
Ricorda concetti di Averroè: nel senso di anima unica, e non personale, e condivisione. Visto nel tuo testo come una sorta di invito a riconoscere la nostra comune umanità e a cercare la pace e l'armonia tra di noi.
Bravo!
Saluti…
Antonio
Voto: 4
Ambizioso? Ci ho provato...
Grazie per il tuo feedback
Re: Commento
I ricordi: che prodigio ! Comunque anche le nostre erano bollenti, e si tergiversava perché buonissime non erano. Ma quello c'era, ed alla fine della cena non avanzava pane sulla tovaglia. Grazie per la condivisione del tuo ricordoVittorio Felugo ha scritto: 20/01/2025, 11:58 Un testo che trasmette pace, serenità, con quella Luna che illumina la notte degli attori del racconto. L'incipit mi ha fatto tornare alla mente le minestrine… Io, però, non ne ho un ricordo piacevole: bollenti come lava, insipide… Perchè ce le propinavano? Boh!
Mi è piaciuto, complimenti!
Re: Commento
Certo, niente brio: solo introspezioni. Ho avuto paura di perdere il lettore per strada nella preghiera, invece a quanto pare è abbastanza digeribile.Ivo Aragno ha scritto: 20/01/2025, 9:08 Piacevole la narrazione nostalgica della minestrina e delle gocce d'olio che si uniscono sulla superficie, quanto gradevole l'uso dei termini che utilizzi nel modo corretto. Manca forse soltanto un poco di brio nel ritmo, che a tratti rallenta. Buona giornata.
Rispetto ad una prima versione l'ho abbreviata.
Grazie per il commento: sono sempre utilissimi
Re: Sarà molto bello
Grazie della tua gentile risposta, Bobinsy,
Tante belle cose,
Antonio Giordano
A rileggerci…
- Eleonora2
- rank (info):
- Correttore di bozze
- Messaggi: 402
- Iscritto il: 04/07/2021, 19:23
-
Author's data
Commento
Re: Commento
Che occhio: complimenti ! Nella prima versione infatti erano in 3, poi ho cambiato, ma mi era sfuggita quella battuta.Eleonora2 ha scritto: 21/01/2025, 15:28 Ricambio la visita perché il testo mi è piaciuto. Hai ottime intuizioni e sai propinarle... come la minestrina! Per me lo stile scorre bene e l'ho letto volentieri Forse sono io a vedere poco, al capitolo - li ho chiamati così - con il titolo di "Supplica"" dici cosa ne dite se ci fermiamo..." come se fossero più di due. La divisione e i relativi titoli rappresentano, per te, solo spezzoni di ricordi? Comunque bella struttura e omaggio alla luna! Ottimo 2025!
Corretto, grazie
La divisione in capitoli... non lo so. No, non è la distinzione dei ricordi. Forse sono fasi, come lo sviluppo di un brano musicale, in cui il tema viene ripreso e variato. Ma nella prima e nell'ultima l'io narrante parla di sè stesso. Di una metafora che si appoggia su un ricordo infantile, ma che produce significati trascendenti. Una scoperta che lo riempie di gioia, e vorrebbe condividere con tutti.
Boh, sconclusionato anch'io ?
- Marino Maiorino
- rank (info):
- Terza pagina
- Messaggi: 886
- Iscritto il: 15/10/2012, 0:01
- Località: Barcellona
- Contatta:
-
Author's data
Commento
è molto, molto poetico, il tutto!
Peró... peró... perché non qui? Cosa ci impedisce di unirci qui anziché dover aspettare il Nulla?
Posso suggerirti la lettura di "Foglia di Niggle", di Tolkien? (Compare in "Albero e Foglia") È un racconto alquanto lungo, ma secondo me risuonerebbe con qualcosa che ho letto qui.
Considerando che Tolkien è certamente IL mio autore favorito...
A presto!

 Racconti alla Luce della Luna
Racconti alla Luce della LunaAutore presente nei seguenti libri di BraviAutori.it:


Autore presente nei seguenti ebook di BraviAutori.it:















Re: Sarà molto bello
@YakamozYakamoz ha scritto: 21/01/2025, 10:28 Ma io sono un lettore che, se entra in empatia con il testo, difficilmente ne perde il senso. L'ho capito subito che il tuo racconto non era "una mera esercitazione di scrittura", come tu hai scritto. Sai come l'ho capito? L'ho capito dai tre "Tac" simili a "piccoli" istanti di "un piccolo evento" che riportano all'immagine iniziale del Prologo: "Accadeva una cosa affascinante: se il cucchiaio toccava due gocce - tac - immediatamente si fondevano in una più grande". Cosa che facevo anche io da piccolo. Perché i bambini, con la loro fantasia, sanno trasformare in un gioco anche buttare giù in un piatto di minestrina. Poi, la frase che sta nell'Epilogo, quella che ho riportato nel mio primo commento e che fa quasi come da "chiosa" al tuo racconto, mi ha fatto accendere come una lampadina nella testa: tipo "epifania", in senso letterario (epifania: si riferisce a un momento di rivelazione o di illuminazione in cui un personaggio o il lettore stesso ha una comprensione improvvisa e profonda di una verità, di un significato o di una realtà nascosta). Quasi subito, a quel punto, ho pensato ad Averroè (il famoso commentatore di Aristotele, citato pure da Dante nella Commedia). E ho sciolto il nodo "comprensivo" di un racconto bello, con una scrittura elegante e un po' "crepuscolare" nella sua composizione frammentaria, ma non difficile da afferrare se uno ci si impegna. Il primo commento l'ho scritto raffazzonando un po', perché col notebook che mi si impallava ogni cinque minuti era difficile farlo bene (cosa che stranamente questa mattina non accade e finalmente riesco a scrivere su LibreOffice).
Grazie della tua gentile risposta, Bobinsy,
Tante belle cose,
Antonio Giordano
A rileggerci…
Scusa se ne approfitto, ma questo forum mi aiuta a capire come vengono percepite le parole.
Vorrei che mi dicessi cosa ti ha trasmesso la frase: "E fu allora che il Nulla si presentò, e si abbracciarono."
Volevo descrivere l'incontro con il trascendente.
Riferire un'esperienza che si può provare in situazioni simili, una sensazione di consolazione, di amore inspiegabile.
Il razionalismo ha svalutato l'esperienza trascendente che pure tutti incontriamo, e parlarne risulta difficile. Ti va di darmi un feedback?
Re: Sarà molto bello
Rispondo brevemente (si fa per dire):Bobinsy ha scritto: 21/01/2025, 18:42 @Yakamoz
Scusa se ne approfitto, ma questo forum mi aiuta a capire come vengono percepite le parole.
Vorrei che mi dicessi cosa ti ha trasmesso la frase: "E fu allora che il Nulla si presentò, e si abbracciarono."
Volevo descrivere l'incontro con il trascendente.
Riferire un'esperienza che si può provare in situazioni simili, una sensazione di consolazione, di amore inspiegabile.
Il razionalismo ha svalutato l'esperienza trascendente che pure tutti incontriamo, e parlarne risulta difficile. Ti va di darmi un feedback?
A una prima lettura, si immagina quel "Nulla" (o vuoto) che tutti noi sentiamo dentro, quelli affettivi di solito fanno più male, e che noi cerchiamo sempre, o in qualche modo, di colmare/compensare/surrogare. Cioè, il "Nulla" come proiezione di voglie, desideri, aspettative non appagate: un amore respinto, un lavoro che ci piace però facciamo altro, o un'altra qualsiasi cosa. Anche il "Nulla" legato ad aspettative, tu hai scritto "Trascendentale/i", mistiche e religiose. Poi esiste anche un altro Nulla: il nulla che ci annulla, ma non nel caso del tuo racconto. Difatti, quando una persona passa a miglior vita, c'è sempre qualcuno che dice: "Non siamo proprio Nulla!", per far intendere la nostra fragilità e precarietà su questa terra: nasciamo, viviamo e poi diventiamo Nulla. Solo ricordo, ma fino a quando qualcuno ci ricorda. Molti poeti, infatti, si autodefinivano o aspiravano a essere "cigni immortali", come dice V. Monti, poeta neoclassico, ma qui più da toni romantici; riporto il verso:
"E quivi
Di te memore, e fatto
Cigno immortal (ché dè poeti in cielo
L'arte è pregio e non colpa), il tuo fedele,
Adorata mia donna,
T'aspetterà, cantando…" (Pel giorno onomastico della mia donna…)
Cigno immortale, ma solo perché di lui resterà memore almeno il nome, anche quando sarà nulla.
Invece, il nulla dei desideri lo esprime molto bene G. Gozzano in questa celeberrima poesia:
"Ti rifarò bella
come Carlotta, come Graziella,
come tutte le donne del mio sogno!
Il mio sogno è nutrito d'abbandono,
di rimpianto. Non amo che le rose
che non colsi. Non amo che le cose
che potevano essere e non sono
state…" (Cocotte)
"Non amo che le cose che potevano essere e non sono state…" = quindi nulla, ma che continuano a esistere "in certo modo" (come pagine non scritte) nel suo/nostro "immaginario".
Sul nulla come incontro con il trascendente: qui è difficile. Perché è più argomento di filosofi o teologi e troppe e molteplici sono le spiegazioni e sfaccettatissime le interpretazioni.
Parmenide, per citare un esempio molto semplice, sosteneva che il "nulla" (e non il trascendentale) non può essere pensato o descritto, poiché il pensiero stesso implica l'esistenza di qualcosa.
Poi c'è il "Nulla/Morte" dei Cristiani, inteso come contrapposizione alla famosa "vita eterna": Via Verità Vita.
Il Nulla dei Buddisti, invece, è legato all'interdipendenza di tutto ciò che esiste; cioè, in parole molto risicate e spicce, nulla di ciò che esiste è "autonomo" ma "interconnesso" e in costante mutamento.
Infine, il nulla "cosmico" che non esiste, perché pure nello spazio più "vuoto" c'è sempre almeno qualche fotone che gironzola da quelle parti; e spero che di questa mia affermazione, Marino Maiorino, essendo astrofisico, me ne dia conferma.
Più esaustivo di questo in un post, non riesco a essere. E spero che il mio feedback ti sia utile.
Ciao, caro Bobinsy, e buon 2025! (gli auguri in ritardo valgono lo stesso, no?)
Antonio
P.S. Poi dicono che commento male! Qualsiasi riferimento è puramente frutto del caso…
Ultima cosa: Namio Intile (molto più competente di me) ha scritto "qualcosina" sul trascendentale; in una risposta a Marino nella scorsa gara. Se non hai "paura", leggila.
Re: Sarà molto bello
E che feedback ! Non osavo tanto: grazie.Yakamoz ha scritto: 21/01/2025, 22:01 Rispondo brevemente (si fa per dire):
A una prima lettura, si immagina quel "Nulla" (o vuoto) che tutti noi sentiamo dentro, quelli affettivi di solito fanno più male, e che noi cerchiamo sempre, o in qualche modo, di colmare/compensare/surrogare. Cioè, il "Nulla" come proiezione di voglie, desideri, aspettative non appagate: un amore respinto, un lavoro che ci piace però facciamo altro, o un'altra qualsiasi cosa. Anche il "Nulla" legato ad aspettative, tu hai scritto "Trascendentale/i", mistiche e religiose. Poi esiste anche un altro Nulla: il nulla che ci annulla, ma non nel caso del tuo racconto. Difatti, quando una persona passa a miglior vita, c'è sempre qualcuno che dice: "Non siamo proprio Nulla!", per far intendere la nostra fragilità e precarietà su questa terra: nasciamo, viviamo e poi diventiamo Nulla. Solo ricordo, ma fino a quando qualcuno ci ricorda. Molti poeti, infatti, si autodefinivano o aspiravano a essere "cigni immortali", come dice V. Monti, poeta neoclassico, ma qui più da toni romantici; riporto il verso:
"E quivi
Di te memore, e fatto
Cigno immortal (ché dè poeti in cielo
L'arte è pregio e non colpa), il tuo fedele,
Adorata mia donna,
T'aspetterà, cantando…" (Pel giorno onomastico della mia donna…)
Cigno immortale, ma solo perché di lui resterà memore almeno il nome, anche quando sarà nulla.
Invece, il nulla dei desideri lo esprime molto bene G. Gozzano in questa celeberrima poesia:
"Ti rifarò bella
come Carlotta, come Graziella,
come tutte le donne del mio sogno!
Il mio sogno è nutrito d'abbandono,
di rimpianto. Non amo che le rose
che non colsi. Non amo che le cose
che potevano essere e non sono
state…" (Cocotte)
"Non amo che le cose che potevano essere e non sono state…" = quindi nulla, ma che continuano a esistere "in certo modo" (come pagine non scritte) nel suo/nostro "immaginario".
Sul nulla come incontro con il trascendente: qui è difficile. Perché è più argomento di filosofi o teologi e troppe e molteplici sono le spiegazioni e sfaccettatissime le interpretazioni.
Parmenide, per citare un esempio molto semplice, sosteneva che il "nulla" (e non il trascendentale) non può essere pensato o descritto, poiché il pensiero stesso implica l'esistenza di qualcosa.
Poi c'è il "Nulla/Morte" dei Cristiani, inteso come contrapposizione alla famosa "vita eterna": Via Verità Vita.
Il Nulla dei Buddisti, invece, è legato all'interdipendenza di tutto ciò che esiste; cioè, in parole molto risicate e spicce, nulla di ciò che esiste è "autonomo" ma "interconnesso" e in costante mutamento.
Infine, il nulla "cosmico" che non esiste, perché pure nello spazio più "vuoto" c'è sempre almeno qualche fotone che gironzola da quelle parti; e spero che di questa mia affermazione, Marino Maiorino, essendo astrofisico, me ne dia conferma.
Più esaustivo di questo in un post, non riesco a essere. E spero che il mio feedback ti sia utile.
Ciao, caro Bobinsy, e buon 2025! (gli auguri in ritardo valgono lo stesso, no?)
Antonio
P.S. Poi dicono che commento male! Qualsiasi riferimento è puramente frutto del caso…
Ultima cosa: Namio Intile (molto più competente di me) ha scritto "qualcosina" sul trascendentale; in una risposta a Marino nella scorsa gara. Se non hai "paura", leggila.
In effetti sono temi estremamente fertili, come le paludi abbandonate, quando finalmente le coltivi.
Non vorrei farti perdere tempo (per cui no problem se non risponderai), ma sono poche le occasioni per dialogare su questo piano.
Metto in chiaro che la mia cultura è tecnica: geometra, chimica all'università ed informatica come professione
Niente filosofia, niente letteratura, niente teologia, niente psicologia
Con queste deformazioni professionali osservo, attraverso la meditazione, il mondo.
I miei erano molto (troppo) devoti, e dall'adolescenza sono materialista.
Il trascendente l'ho incontrato molte volte (quando hai 70 anni, di storie ne hai tante) ed ho capito che ci si arriva per sottrazione.
Quando togli (o ti viene tolto) tutto, e ti trovi a togliere anche il tempo, eccolo lì.
Luminoso: un oceano di pace.
Il "nulla" che hai citato (con splendidi riferimenti letterari) non corrisponde esattamente a quello che sento.
Ma probabilmente ognuno sente in modo diverso
Mi assomigliano a viottoli che portano lì
Ma lì, veramente, puoi solo "intravedere", perchè se ci sei, non sei più qui.
Ed io sono ancora qui, coi miei ricordi, i miei acciacchi, i miei fardelli
Fine della biografia.
Adesso però bisogna che mi dedico ai rifermenti che tu e "@Marino Maiorino" ("Albero e Foglia") mi avete passato.
Grazie di nuovo: a presto
Roberto
(Bobinsky è lo pseudonimo che usavo adolescente, per firmare fumetti.
Bob = Roberto; sky richiamava la lingua polacca; i polacchi mi stavano simpatici perchè perdenti
Bobinsy è un errore di ortografia quando mi sono registrato
ma forse per questo mi identifica anche meglio)
Re: Sarà molto bello
Ciao, Bobinsy, (proviamo un ultimo tentativo.)Bobinsy ha scritto: 22/01/2025, 15:05 E che feedback ! Non osavo tanto: grazie.
In effetti sono temi estremamente fertili, come le paludi abbandonate, quando finalmente le coltivi.
Non vorrei farti perdere tempo (per cui no problem se non risponderai), ma sono poche le occasioni per dialogare su questo piano.
Metto in chiaro che la mia cultura è tecnica: geometra, chimica all'università ed informatica come professione
Niente filosofia, niente letteratura, niente teologia, niente psicologia
Con queste deformazioni professionali osservo, attraverso la meditazione, il mondo.
I miei erano molto (troppo) devoti, e dall'adolescenza sono materialista.
Il trascendente l'ho incontrato molte volte (quando hai 70 anni, di storie ne hai tante) ed ho capito che ci si arriva per sottrazione.
Quando togli (o ti viene tolto) tutto, e ti trovi a togliere anche il tempo, eccolo lì.
Luminoso: un oceano di pace.
Il "nulla" che hai citato (con splendidi riferimenti letterari) non corrisponde esattamente a quello che sento.
Ma probabilmente ognuno sente in modo diverso
Mi assomigliano a viottoli che portano lì
Ma lì, veramente, puoi solo "intravedere", perchè se ci sei, non sei più qui.
Ed io sono ancora qui, coi miei ricordi, i miei acciacchi, i miei fardelli
Fine della biografia.
Adesso però bisogna che mi dedico ai rifermenti che tu e "@Marino Maiorino" ("Albero e Foglia") mi avete passato.
Grazie di nuovo: a presto
Roberto
(Bobinsky è lo pseudonimo che usavo adolescente, per firmare fumetti.
Bob = Roberto; sky richiamava la lingua polacca; i polacchi mi stavano simpatici perchè perdenti
Bobinsy è un errore di ortografia quando mi sono registrato
ma forse per questo mi identifica anche meglio)
Azzardo un approccio di analisi pseudo-psicanalitica. Pseudo perché la psicoanalisi considera Dio e affini come "archetipi". Come "insieme di teorie" di studio dei processi mentali, io considero la psicoanalisi, e ogni sua derivazione, troppo semplificante e pretenziosa. Ma le "basi" della "disciplina", che hanno influenzato tutto il XX secolo, possono essere utili per interpretare un testo letterario. E spesso, cosa strana, funzionano anche: o almeno così dicono in giro.
4)- Nulla
Poco distante anche Luca tornava a casa, costeggiando una siepe.
Le cose non stavano andando per il verso giusto.
Provava un senso di delusione e si sentì improvvisamente solo.
Non c'era nulla per lui quella sera.
Neppure le stelle.
Camminava con passo stanco.
Chissà quale fiore notturno segnalò la sua presenza e sparì dopo pochi passi. (Qui ricorda "Di sera una geranio", novella di Pirandello.)
Restò il silenzio.
Si fermò per fare tacere anche il suono dei suoi passi. (Cerca un silenzio perfetto.)
Sentì il suo respiro. (Si accorge che respira.)
Lo trattenne e sentì il cuore nel petto. (Vuole ancora più silenzio e sente il cuore battere, perché esiste sempre un rumore che sta più in sottofondo.)
Udiva gli alberi tutto attorno scrollare delicatamente le foglie. (Sente tutto quello che ha attorno: scrollare le foglie. Perché è in una sintonia più profonda con quello che lo circonda.)
Forse qualche animale si era mosso. (Fa un'ipotesi.)
Riprese a respirare: non era più solo. (Non è più solo perché è in connessione col mondo. Anzi, pure il suo inconscio è connesso.)
"E fu allora che (a lui) il Nulla si presentò e si abbracciarono." Lui è l'Io (mediatore tra le nostre pulsioni e la realtà), il Nulla è l'Es (le pulsioni, gli istinti). Quindi, questa scena potrebbe essere vista anche come abbandono dell'Io per ritornare a una situazione pregressa di solo Es, perché l'Io nasce dopo Es e poi il Super-Io. Un ritorno all'Es è un'esperienza "trascendentale". Nell'Es c'è l'inconscio e in esso c'è Dio (forse). Ritorno quindi a una situazione "primitiva" di pura connessione con la natura e Dio (e non necessariamente un Dio che conosciamo attraverso la fede, ma comunque un Dio). Dio è creatore di ogni cosa e ogni cosa ritorna a Dio: perciò ritorno a un'unione comune, in comunione con Dio, o chi per lui.
Concludendo:
"L'abbraccio con il Nulla può essere visto come un ritorno a una condizione originaria di unità con tutto ciò che esiste. Una sorta di negazione del "sé" in una ricerca di una pace interiore che trascende la dualità tra soggetto e oggetto, tra coscienza e inconscio."
Come le piccole gocce d'olio che si uniscono nella tua minestrina. Poi esistono anche altre unità/entità superiori: la bottiglia dove stava tutto l'olio, poi la latta, la botte, il frantoio, le olive, l'albero, il seme, e via via sempre procedendo di questo passo verso "non so cosa".
Spiego velocemente, approssimando molto, i concetti di Es, Io e Super-Io (tipo Bignami):
Es = Istinti (e ogni cosa che ne deriva)
Io = Pensiero C.s.
Super-Io = Morale C.s.
Saluti…
Antonio
A rileggerci…
P.S. Se vuole la fattura, si rivoga alla mia infermiera! (scherzo!)
Re: Sarà molto bello
Alla prossima (sono in debito)
-
Namio Intile
- rank (info):
- Terza pagina
- Messaggi: 769
- Iscritto il: 07/03/2019, 11:31
-
Author's data
Commento
Tac: due gocce si erano sono fuse assieme.
Adoperi poi le virgolette sia per virgolettare parole che per circoscrivere i discorsi diretti. O l'uno o l'altro.
Il tema è quello dell'unione, dell'abbraccio che affronti sin dal prologo, per via di metafora, che nella prosieguo. Il prologo non è male, come la supplica, ma nell'insieme, a mio avviso, la struttura a brevi paragrafi e la forma quasi a versi pone in bella mostra il messaggio, il tema, la verità dell'autore, come farebbe un componimento poetico. E lo fa senza il sostegno di una narrazione, di un intreccio, di una trama, che mancano. E quindi anche il messaggio viene svilito dalla struttura complessiva.
La differenza tra poesia e prosa è sostanziale. La poesia cerca la verità, e la cerca per via metaforica, allegorica, sinestetica, per figure e verosimiglianze. La poesia adopera le parole in modo inconsueto, alle volte le costruisce, lavora per riflessi e immagini, per associazioni.
La prosa fa tutt'altro. Narra, sviluppa un discorso, costruisce strutture, intreccia relazioni, descrive comportamenti, rappresenta mondi. Non cerca la verità, la prosa è mimesi, imitazione della realtà e le verità possono essere molteplici, dell'autore, dell'autore implicito, dei protagonisti, degli antagonisti e via discorrendo.
Quindi la scelta tra prosa e poesia non è solo formale, ma sostanziale, ideologica.
Mi ha colpito quell'abbraccio al Nulla. Ma anche qui: attenzione, l'Occidente oggi scambia il Nulla per una divinità, gli dà una dimensione trascendente. Non trascendentale, che è cosa diversa. Ma il nulla non è né immanente né trascendente. Il nulla NON è e basta. Chi abbraccia il Nulla e lo prende per un trascendente, lo adora come un trascendente, è un nichilista. Un adoratore del nulla. E gli adoratori del nulla, i nichilisti, preparano e anticipan la fine di ogni cosa desiderano l'oblio che è l'anticipazione della morte.
Quindi, seppure l'immagine di quell'abbraccio sia poetica, in realtà nasconde un messaggio terribile.
E quando si scrive poesia coi messaggi bisogna star attenti, perché sono la verità e vengono trattati come tali.
Nel caso della prosa il discorso è diverso, totalmente diverso. La prosa ti permette di scrivere anche del Nulla colla maiuscola. Ed è questa la grandezza della narrazione, come la Verità della poesia.
Io non sono un cercatore di Verità, e quindi la poesia non mi riesce.
Con questo testo io invece non vedo ancora né un narratore né un poeta. Devi decidere se essere un uomo di verità o un uomo di libertà, per parafrasare il Così parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo, se qualcuno se lo ricorda ancora.
A rileggerti.
Re: Commento
Namio Intile ha scritto: 29/01/2025, 17:06 Ti segnalo questo refuso: erano sono
Tac: due gocce si erano sono fuse assieme.
Adoperi poi le virgolette sia per virgolettare parole che per circoscrivere i discorsi diretti. O l'uno o l'altro.
Il tema è quello dell'unione, dell'abbraccio che affronti sin dal prologo, per via di metafora, che nella prosieguo. Il prologo non è male, come la supplica, ma nell'insieme, a mio avviso, la struttura a brevi paragrafi e la forma quasi a versi pone in bella mostra il messaggio, il tema, la verità dell'autore, come farebbe un componimento poetico. E lo fa senza il sostegno di una narrazione, di un intreccio, di una trama, che mancano. E quindi anche il messaggio viene svilito dalla struttura complessiva.
La differenza tra poesia e prosa è sostanziale. La poesia cerca la verità, e la cerca per via metaforica, allegorica, sinestetica, per figure e verosimiglianze. La poesia adopera le parole in modo inconsueto, alle volte le costruisce, lavora per riflessi e immagini, per associazioni.
La prosa fa tutt'altro. Narra, sviluppa un discorso, costruisce strutture, intreccia relazioni, descrive comportamenti, rappresenta mondi. Non cerca la verità, la prosa è mimesi, imitazione della realtà e le verità possono essere molteplici, dell'autore, dell'autore implicito, dei protagonisti, degli antagonisti e via discorrendo.
Quindi la scelta tra prosa e poesia non è solo formale, ma sostanziale, ideologica.
Mi ha colpito quell'abbraccio al Nulla. Ma anche qui: attenzione, l'Occidente oggi scambia il Nulla per una divinità, gli dà una dimensione trascendente. Non trascendentale, che è cosa diversa. Ma il nulla non è né immanente né trascendente. Il nulla NON è e basta. Chi abbraccia il Nulla e lo prende per un trascendente, lo adora come un trascendente, è un nichilista. Un adoratore del nulla. E gli adoratori del nulla, i nichilisti, preparano e anticipan la fine di ogni cosa desiderano l'oblio che è l'anticipazione della morte.
Quindi, seppure l'immagine di quell'abbraccio sia poetica, in realtà nasconde un messaggio terribile.
E quando si scrive poesia coi messaggi bisogna star attenti, perché sono la verità e vengono trattati come tali.
Nel caso della prosa il discorso è diverso, totalmente diverso. La prosa ti permette di scrivere anche del Nulla colla maiuscola. Ed è questa la grandezza della narrazione, come la Verità della poesia.
Io non sono un cercatore di Verità, e quindi la poesia non mi riesce.
Con questo testo io invece non vedo ancora né un narratore né un poeta. Devi decidere se essere un uomo di verità o un uomo di libertà, per parafrasare il Così parlò Bellavista di Luciano De Crescenzo, se qualcuno se lo ricorda ancora.
A rileggerti.
Perbacco; ti ringrazio per il tempo dedicato a questa lezione, interessante; mi ha fatto comprendere molte cose.
E' vero, ho un piede sulla prosa, ed uno sulla poesia, e, come quando si scende dal vaporetto, non è il caso di sostarci a lungo.
Ma l'incertezza ha caratterizzato tutta la mia vita... chissà.
Ti vorrei però portar via qualche minuto sul tema del Nulla, che era centrale anche nel mio precedente "breve".
In meditazione, il nulla potremmo rappresentarlo come uno stato della consapevolezza, raggiungibile per sottrazione.
Quando ogni cosa in transito nella mente la lasci scivolare via, considerandola "altro da te", ed hai un intento benevolo, fai un'esperienza particolare.
A me, materialista, non interessa classificarla mistica; con approccio empirico ne posso descrivere le caratteristiche: è uno stato di pace, in cui il tempo perde significato; tutto del mondo materiale perde significato.
E non resta nulla, oltre alla tua consapevolezza.
Se non resta nulla, direi che possiamo chiamarla trascendente;
A questo tipo di esperienza ho fatto riferimento con la parola "Nulla".
Ma non è un Nulla drammaticamente nichilista: è un nulla di pace, d'amore universale. Ed è questa universalità a cui faccio riferimento con l'unione.
La fusione di due gocce, da due ne fa una. L'unione è il dissolvimento dell'uno nel tutto (o nel nulla, se consideraimo che dell'uno precedente non resta nulla).
Ma non è necessario praticare la meditazione; è una esperienza abbastanza comune.
Nel racconto precedente, il protagonista la raggiungeva con il conto alla rovescia: "Dopo lo zero non c'è nulla" e quella semplice pratica lo portava ad uno stato di pace.
Oppure, avendo ricevuto una diagnosi infausta, immaginava il nulla dopo la morte, e lo percepiva come spiraglio di luce.
In questo racconto, invece, il senso di pace è raggiunto con l'immersione nella natura.
Provando a disfarsi di dispiaceri, ruoli, impegni, abitudini... dell'IO, ecco che ci si può trovare uniti
Un'unica natura ci rende ancor più che fratelli: proprio la stessa cosa.
Mi sono dilungato perchè le tue spegazioni erano molto pertinenti, ma evidentemente le parole che ho scritto
non sono riuscite a portarti dove io ero, e la parola Nulla ha creato confusione.
Un po' lo temevo
Penso che ci proverò ancora, perchè è un tema che sento intensamente.
Re: Sarà molto bello
"Di sera, un geranio", Pirandello.
L'avevo scritto prima da qualche parte, ed era pure un invito a leggerla, è solo una pagina.
Andare nel "nulla" è la morte. Perché "Di sera, un geranio" parla di "Morte".
Ciao, Bobinsy
-
Namio Intile
- rank (info):
- Terza pagina
- Messaggi: 769
- Iscritto il: 07/03/2019, 11:31
-
Author's data
Re: Sarà molto bello
Il linguaggio comune tende a corromperne il senso e il significato, ma se hai due minuti provo a fare chiarezza.
L'Empirico è il contenuto dell'esperienza percettiva, che quindi ha sempre una particolare posizione rispetto alle coordinate del tempo e dello spazio.
Io ho dei fruttuosissimi alberi di cachi del mio giardino: sono oggetti empirici, perché possono essere visti e toccati posizionandosi in un determinato luogo dello spazio, quello appunto dove si trova il giardino, e in un determinato periodo di tempo, quello durante il quale i detti cachi esistono. Allo stesso modo, un qualsiasi sentimento provato in una qualsiasi circostanza è empirico, perché avvertito da una percezione della propria interiorità vissuta in un determinato momento del tempo. Di conseguenza un concetto è empirico quando la sua formulazione astratta rinvia, anche tramite altre astrazioni, a un elemento percettivo.
Considera dunque, empirico come legato alle nostre percezioni, ai nostri sensi e all'estensione di essi.
Quindi le tue sensazioni, compreso il tuo nulla è EMPIRICO e NON trascendente.
Ci aggiungo che le tre nozioni di empirico, trascendente e trascendentale devono essere comprese nella loro articolazione unitaria perché ciascuna di esse possa venir compresa nella sua specificità. Ciascuna di queste tre nozioni, cioè, può essere compresa in se stessa soltanto all’interno di una comprensione della sua intrinseca relazione con la totalità formata da essa e dalle altre.
L’empirico, infatti, se inteso empiricamente, non mostra di che cosa consista la sua empiricità, non si rende comprensibile come tale. L’empirico, cioè, può essere compreso come empirico soltanto in maniera NON empirica. Come appare l’empirico, infatti, se viene inteso esclusivamente attraverso la sua empiricità? Appare come dato immediato della coscienza. Consideriamo un qualsiasi oggetto empirico, ad esempio i cachi del mio giardino. Essi sembrano dati alla percezione: in condizioni ambientali normali, una persona dotate di normali facoltà percettive che si trovi nel mio giardino al cui interno crescono i miei cachi, e guardi nel posto dove essi si trovano, non può che vederli, e non può far agire la sua vista in modo da percepire, al loro posto, nello stesso luogo spaziale, una melograno o degli albicocchi. Esso sembra costituito nell’immediatezza: chi li vede nel giardino li riconosce come alberi nel momento stesso in cui li vede, e li riconosce come cachi non appena vede penderne i loti, il loro frutto, dai rami.
Ma le cose non stanno come sembrano. Marx osserva ironicamente, nell’”Ideologia tedesca”, a proposito della certezza sensibile del dato immediato posta da Feuerbach a fondamento di ogni verità, che lo stesso albero di cachi che ogni mattina si offre alla certezza sensibile di Feuerbach dal suo giardino, vi si trova solo perché sono stati trapiantati in Germania dall’Asia qualche secolo prima grazie ad un’espansione dei commerci, perché c’è precedentemente stata una trasformazione sociale che ha portato a tale espansione dei commerci, e così via. Senza questo sviluppo storico, Feuerbach non vedrebbe là dove lo vede il suo albero, che perciò non è affatto un dato, ma un posto, ovvero una costruzione storica.
Ciò che è empirico viene chiamato anche fatto. Questo termine, benché sia usato come sinonimo di dato, ha una portata semantica più appropriata alla realtà di ciò a cui è riferito: in quanto participio passato del verbo fare, indica non una datità, ma il risultato di una costruzione della prassi. Il fatto, cioè, è fatto dalla storia, sotto un duplice aspetto: la storia ne produce il contenuto, e dalla storia derivano le costellazioni mentali in riferimento alle quali le percezioni ne ritagliano la configurazione dai suoi sfondi.
La storia, d’altra parte, sgorga dall’antropologia e vi si inscrive. È anche vero che l’antropologia è plasmata dalla storia e vi si inscrive. Questi due lati debbono essere contemporaneamente ammessi. L’uomo vive immerso nei fatti storici, ed è lui stesso un fatto storico. È anche il fare da cui i fatti, e lui stesso come fatto, sono fatti. L’empirico è il prodotto di questa dialettica antropologica. Al di fuori di essa, e di una appropriata comprensione di essa, l’empirico non si rende intellegibile nel suo spessore di realtà, la realtà che non empiricamente lo ha generato, e mostra soltanto la sua superficie percettivamente rilevabile. Questa superficie, proprio perché astratta dalla realtà di cui è l’ultima manifestazione, appare come datità. Assumerla come tale è la scelta originaria di ogni empirismo, una scelta che tuttavia non è empiristica, bensì METAFISICA. La scelta di prendere il fatto come dato di fatto non è un dato di fatto, ma è appunto uno scegliere, un fare, un oltrepassare la datità.
La scelta metafisica dell’empirismo è di fare del fatto un dato, passivizzando rispetto ad esso il pensiero e la comprensione. Spero di esser stato chiaro.
Quanto al Trascendente, esso è invece ciò che trascende la dimensione spazio-temporale del mondo empirico, vale a dire ciò che sussiste oltre di esso. È dunque l’aldilà non raggiungibile, neppure in linea di principio, lungo la sequenza delle concatenazioni fattuali. Quindi il tuo Nulla non può essere trascendente.
La trascendenza così intesa è, sul piano logico, una contraddizione in termini. Il problema se la trascendenza esista o meno secondo la sua pura definizione, quindi, non si pone neppure. Una questione di fatto sull’esistenza o sulla non esistenza si pone infatti per tutto ciò la cui esistenza non sia incompatibile con la logica del linguaggio. È ad esempio molto improbabile che esista sul nostro attuale pianeta una città in cui durante lo scorso anno non sia stato commesso neppure un reato. Si potrebbe tuttavia ricercare se per caso esista, perché la definizione di città e la definizione di rispetto della legge penale non sono incompatibili. Non si potrebbe invece nemmeno cercare, senza cadere nell’assurdo, un triangolo quadrato. Ma la trascendenza è come un triangolo quadrato, che se è quadrato non è più triangolo e viceversa. Trascendenza è infatti ciò che è aldilà o al di fuori di ogni spazio. Ma queste espressioni sono contraddittorie, perché “aldilà” e “ al di fuori” sono determinazioni spaziali, e hanno senso solo se riferite a entità nello spazio. Si può essere “al di fuori di questa stanza”, “al di là del sistema solare”, non si può essere “al di là dello spazio”.
Come ha potuto essere allora il trascendente concepito lungo tutta la storia umana fino ad oggi? Si è riusciti a pensare il trascendente solo perché lo si è concepito NON in modo trascendente, che sarebbe impossibile, ma in modo EMPIRICO. Nella misura in cui è stato pensato, il trascendente è stato pensato come iperuranio, cioè come un sovramondo, immagine trasfigurata del mondo sensibile, una specie di attico nobile del grande palazzo dell’empirico. Il trascendente, in altri termini, non può essere posto che come raddoppiamento IDEALIZZATO dell’empirico, come un empirico del piano di sopra privo dei difetti dell’empirico del piano terra della nostra fattuale esperienza. Lo sapeva Platone quando, nel Parmenide (il suo dialogo destinato, a differenza degli altri, più ai dotti che alla divulgazione), mostra come le idee poste in modo trascendente vengano necessariamente o rese inintellegibili o rese intellegibili solo in modo empirico. Lo sapeva Hegel quando, nella sua Fenomenologia dello Spirito, mostra come la coscienza scettica, che non crede in nulla che non sia una particolarità empirica, e la coscienza duplicata, che crede nell’intrasmutabile, siano ciascuna l’altra faccia dell’altra, e si generino l’una dall’altra. Tiro una parentesi: per chi è abituato alle ricostruzioni usualmente adoperate della storia della filosofia, che attribuiscono a Platone la trascendenza delle idee e ad Hegel la logicizzazione della storia, le cose appena dette appariranno straordinarie. Per sincerarsi che sono vere, però, basta leggere i testi di Platone e di Hegel a cui si è fatto riferimento. D’altra parte, il fatto che appaia generalmente incredibile un Platone negatore della trascendenza delle idee, così come un Hegel negatore del panlogismo dei fatti, non è che un aspetto della scomparsa della conoscenza filosofica. Chiusa parentesi.
Il trascendente, dunque, non è mai davvero concepito secondo la sua definizione linguistica, che è come tale inconcepibile, ma è sempre concepito come un altro empirico sovrastante il nostro empirico. Questo sovraempirico è riempito di esigenze antropologiche, sia ontologiche che psicologiche, storicamente non legittimabili su base immanentistica, ed è tale suo contenuto che gli assicura una solida consistenza storica. I contenuti psicologici proiettati sul trascendente, che trascendente non è se non come sovraempirico, veicolano privilegi classisti, chiusure sociali ed istanze repressive che hanno fatto la violenza crudele delle religioni da quando sono nate fino ad adesso, Mito compreso. Ma sul trascendente sono stati proiettati anche contenuti genuinamente ontologici, che rendono così filosoficamente ricche di insegnamenti anche metafisiche compiutamente teologali, come, ad esempio, quelle di Agostino o di Eriugena. A questo proposito la tesi di Hegel è che certi saperi basati su assolutezze trascendenti non sono falsi saperi, nonostante che la trascendenza della loro assolutezza sia falsa, e non sono neppure veri saperi: sono piuttosto saperi apparenti, nel senso che un contenuto realmente umano vi appare nella forma illusoria di un ente extraumano. Non so se mi sono spiegato.
Il trascendente e l’empirico, quando vengono contrapposti l’uno all’altro, costituiscono una falsa opposizione, perché l’empirico considerato solo empiricamente ha un vuoto di significato che rinvia al trascendente come unico suo possibile riempimento, ed il trascendente ha un vuoto di contenuto che rinvia all’empirico come unica sua possibile consistenza. Questo reciproco rinvio, d’altra parte, non è comprensibile che da un punto di vista che non sia né empirico né trascendente, ma trascendentale.
Ed eccoci così al terzo concetto: il trascendentale. Delle tre questa può essere considerata la nozione più filosofica, e per questo più comunemente oscura e più facilmente equivocabile e distorcibile. Darne una definizione rigorosa serve solo fino a un certo punto a renderla comprensibile, in quanto tale definizione ha un significato soltanto nella dimensione aperta dalla filosofia, dimensione alla quale la stragrande maggioranza dell'umanità è esistenzialmente estranea.
Partiamo comunque da una definizione formalmente precisa. Trascendentale è la condizione universale del manifestarsi della realtà come tale. Ossia, è la forma della rivelazione della cose nella loro compiuta realtà. Il trascendentale non esiste, nel senso in cui esistono gli enti, ma è l’essere di tutte le cose che esistono. (Quanto a una definizione del concetto di essere, contrapposto a ente - ciò che esiste -, lo rinvio molto brevemente in basso, nel trattare del nichilismo.)
Il tempo è trascendentale, perché gli eventi non si manifestano come eventi reali se non nella loro collocazione temporale. La libertà è trascendentale, perché gli eventi non si generano come tali, nella loro realtà, se non in quanto libere creazioni o assunzioni dell’uomo. La finitudine è trascendentale, perché le cose non si manifestano se non entro i limiti che, nel renderle finite, ne determinano le specifiche realtà. La giustizia è trascendentale, perché le cose umane si manifestano sempre in una reciprocità di relazioni la cui complessiva configurazione è sempre valutabile come giusta o non giusta.
E cos'è la filosofia, se non esperienza del trascendentale?
Questi succinti perché, la cui esplicitazione argomentativa è il succo della filosofia, sollecitano intanto una prima intuizione del piano su cui la filosofia stessa si svolge. Si tratta di un accesso meno lineare di quello ad altre discipline, in quanto, se è vero che per comprendere il significato della filosofia è necessario comprendere il trascendentale, è anche vero che per comprendere il significato del trascendentale è necessario rappresentarsi il piano della filosofia. Filosofia è esperienza del trascendentale.
Il trascendentale non è né trascendente né empirico, ed è la spiegazione del generarsi del trascendente e dell’empirico. Il tempo, ad esempio, non è certo trascendente, in quanto l’idea del trascendente è l’essere al di là del tempo, ed il tempo non può certo essere al di là di se stesso. Ma il tempo non è neanche empirico, in quanto non è un contenuto dell’esperienza percettiva, essendone la forma: non posso dire che lì c’è il tavolo, lì c’è la sedia, lì c’è la parete, lì c’è la finestra, e lì c’è il tempo, come se fosse un oggetto tra i tanti, e quindi empirico. Perché è la forma in cui tutti si dispiegano, ed è proprio per ciò trascendentale.
L’empirico è il prodotto del trascendentale, di cui però non esprime, empiricamente considerato, se non il riflesso (questo, detto incidentalmente, è il senso veritativo del mito platonico della caverna). Ad esempio: ogni oggetto empirico è temporalmente costituito, ma non manifesta la sua temporalità costitutiva ad una considerazione meramente empirica, cioè come datità sensibile. Il ciliegio di un giardino sta nel giardino durante un certo tempo, (non c’era, ad esempio, un secolo fa, ed un secolo fa non c’era nemmeno il giardino, anch’esso empirico e dunque temporale). Ma ciò che vedo e tocco del ciliegio sono le sue ciliegie, il loro colore rosso, le foglie, la legnosità del tronco, non certo il tempo del suo dispiegarsi. L’intuizione della temporalità costitutiva del ciliegio è una sua intuizione ideale, non empirica, è una intuizione della trascendentalità propria dell’empirico.
L’empirico, che è sempre formato dal trascendentale, non sempre, anzi raramente, lo esprime con una certa compiutezza. Ciò rende più difficile rilevare la presenza del trascendentale nell’empirico, e l’incapacità di rilevarlo è la sorgente generativa del trascendente. Il trascendente è posto infatti come un trascendentale al di là del trascendentale dell’empirico non riconosciuto come tale. Ma poiché non è logicamente concepibile un trascendentale al di là della forma trascendentale dell’empirico, i suoi termini sono sempre contradditoriamente tratti dall’empirico contenuto nel suo non riconosciuto perimetro trascendentale. E’ come se, non conoscendo la struttura scheletrica (il trascendentale) che tiene eretto un corpo (l’empirico), lo si immaginasse sorretto da grandi braccia invisibili (il trascendente), sul modello delle braccia visibili (l’empirico dal cui raddoppiamento trasfigurato si genera il trascendente) che sostengono gli oggetti.
Ora, esiste un quarto concetto con cui l'umanità ha a che fare da millenni: il nichilismo.
Il rifiuto del trascendentale è il nichilismo. Del trascendentale, bada bene, non del trascendente. Nichilismo, infatti, è l’assunzione di un esistere senza essere. Ma, poiché l’essere dell’esistere è il trascendentale, in quanto condizione universale della realtà, quindi del suo essere (distinto dall’esistere), il nichilismo, in quanto negazione dell’essere dell’esistere, non è che il rifiuto di assumere la realtà nella sua trascendentalità.
Esistere ed essere, che nel linguaggio ordinario sono sinonimi, non lo sono nel linguaggio filosofico, ed anzi la dimensione propria della filosofia è stata anticamente aperta da Parmenide proprio attraverso la distinzione tra esistere ed essere.
Esistere significa apparire nella dimensione empirica. Un albero, un fiume, una casa, una città esistono in quanto sono rinvenibili nell’esperienza. Essere è la permanenza ed il significato universali dell’esistere. Il nulla è il non essere, non il non esistere. Un asino con le ali non esiste, in quanto non rinvenibile empiricamente. Un’azienda che mira soltanto al profitto monetario, e che quindi non assicura alcuna stabilità ai suoi lavoratori, ritenuti sempre licenziabili, ed alcun significato umano al loro lavoro, fatto oggetto soltanto di sfruttamento, e che è instabile nel suo stesso assetto organizzativo e territoriale, rimesso sempre in gioco in rapporto alle convenienze di mercato, una tale azienda certo esiste, ma come nulla di essere.
Il nichilismo è quella condizione esistenziale e storica entro la quale l’essere è considerato nulla, in conseguenza del fatto che il nulla è stato scambiato per essere. La pseudofilosofia odierna, quando pensa al nichilismo, pensa a Nietzsche, per il quale il nichilismo nasce con la morte di Dio, si completa con la negazione dell’idealità sovrasensibile quale dimensione dei valori, ed apre così la strada al suo superamento nella trasvalutazione di tutti i valori attraverso il dire di sì alla vita sensibile. Secondo Nietzsche, inoltre, il germe remoto del nichilismo sta nella contrapposizione platonico-parmenidea del divenire, portatore del nulla, all’idealità sovrasensibile, paradigma dell’essere. Tale idealità, infatti, è destinata, non appena pensata in termini razionali, a dissolversi in un divenire non accettato come essere proprio perché originariamente concepito in riferimento ad essa, generando così la situazione del nichilismo.
Ma Nietzsche non considera che l’adesione all’idealità trascendentale dell’essere, come viene argomentata nella tradizione filosofica a partire da Parmenide e Platone, è in realtà la configurazione non nichilistica dell’esistenza. Il germe nascosto del nichilismo sta invece nella credenza in entità trascendenti, che, destituendo di significato proprio l’immanenza antropologica, assume come essere di tale immanenza quelle nullità empiriche che, per tale credenza, rappresentano la trascendenza. Non dunque la morte del Dio trascendente apre lo spazio del nichilismo, ma, al contrario, proprio la sua vita nella credenza umana. Si è detto come il trascendente, costituito come riempimento di senso di un empirico che ne è stato svuotato perché assunto senza trascendentalità, sia tuttavia privo di ogni consistenza che non sia empirica. Per questo ogni divinità trascendente che compare nella storia vi si rappresenta non, per così dire, in proprio, ma attraverso un empiricissimo clero che la mette avanti come sua legittimazione. Ogni clero è un nulla (almeno nella misura in cui non si declericalizza esprimendo la trascendentalità), scambiato però dai suoi fedeli per essere, in quanto rappresentante dell’essere divino (un impensabile che trae pensabilità proprio dal clero che, nel rappresentarlo, lo fa consistere). Ma il nulla scambiato per essere è la vera base del nichilismo, di cui la riduzione dell’essere al nulla è una semplice conseguenza. E poiché ciò che fa scambiare per essere la nullità di ogni organizzazione clericale è la credenza in un Dio trascendente, è appunto la vita, non la morte, di questo Dio, ad aprire la strada al nichilismo.
La morte del Dio trascendente, d’altro canto, dilata la voragine del nichilismo, perché avviene storicamente non mediante un recupero dell’essere trascendentale, ma spostando il meccanismo dello scambiare il nulla per essere (scambio che è la sostanza del nichilismo) dal quel nulla che è rappresentato dal clero e dall’etica autoritario-repressiva, a quell’altro nulla che è rappresentato dal potere della ricchezza monetaria e dalla forza della tecnica. La genialità filosofica di Jacobi ha indicato la voragine del nichilismo, fin dall’inizio dell’Ottocento, nella concezione romantica che, dissolvendo la sostanzialità del reale nell’attività soggettiva, ha trasformato la soggettività in forza produttiva di sempre nuovi fenomeni attraverso l’annichilimento dei precedenti. Hegel, accettando la soggettività creatrice come spazio indispensabile alla libertà, ha indicato la via per mantenerla sostanziale, concependola non più romanticamente, ma logicamente, entro categorie che siano limiti trascendentali al suo dispiegarsi. Ma la sintesi filosofica di Hegel è stata espulsa dalla prassi storica che, sfociando nel capitalismo e nella tecnica, è diventata demiurgia nichilistica.
L’epoca moderna, comunque se ne vogliano fissare i limiti cronologici sempre convenzionali, è caratterizzata dalla concezione della libertà come autodeterminazione della soggettività individuale (concezione diventata per noi ovvia, ma estranea alle epoche precedenti, che avevano inteso in altri modi la condizione libera), e dall’obiettivo di emancipare la soggettività individuale da tutte le autorità e le comunità capaci di soffocarne la creatività nel pensiero e nella prassi. La modernità è cioè come tale emancipatoria, e coincide nel suo concetto con i caratteri giuridici, politici, economici e scientifici della cosiddetta civiltà occidentale, distinta dall’Occidente come spazio geografico e come storia complessiva svoltasi entro tale spazio.
Da quando, nel 1979, Jean François Lyotard ha pubblicato il suo storico saggio “La condizione postmoderna”, ha cominciato a diffondersi la consapevolezza che la modernità è tramontata, e viviamo nel postmoderno. Ma che cosa deve intendersi per postmoderno? Lyotard, che ne ha in un certo senso coniato il termine sostantivo, traendolo da una aggettivazione data negli anni precedenti, a cominciare da Touraine, alla cosiddetta società postindustriale, lo ha concepito, in sostanza, come un nuovo statuto del sapere. Il sapere premoderno era costituito da quelle che lui ha chiamato “grandi narrazioni”, perché raccontano un senso complessivo e finalistico della storia umana, o “metanarrazioni”, perché erano riferite a molteplici narrazioni specifiche di fatti particolari come intepretazioni veritative di esse. Il sapere moderno si è legato alla potenza pragmatica di una nuova scienza capace di dominare l’empirico attraverso il linguaggio matematico e tecnico, la scienza moderna, appunto. Questa scienza si è all’inizio inscritta nell’obiettivo emancipatorio della modernità falsificando tutte le metanarrazioni premoderne soffocatrici della libera soggettività individuale, rivelando e poi creando nuovi fatti incompatibili con esse. Tale inscrizione è stata tuttavia opera di altre narrazioni, da quella baconiana a quella illuministica, da quella positivistica a quella popperiana, che hanno legittimato le scoperte scientifiche come epopea di disvelamento delle cose e di liberazione dell’uomo. Ma anche questa narrazioni si sono via via rivelate infondate. È così nata quella incredulità generale nei confronti della metanarrazioni che secondo Lyotard definisce il postmoderno. La caduta di ogni valenza legittimatoria delle grandi narrazioni cambia lo statuto del sapere. Il postmoderno è un modo di concepire il sapere oltre ogni metafisica, oltre ogni teoria di legittimazione, oltre ogni idea di formazione dello spirito, in cui il sapere diventa trattamento operativo delle informazioni.
Sviluppando queste considerazioni e andando oltre lyotard stesso, si può dire che il postmoderno è una forma di legittimazione del sapere attraverso la potenza produttrice delle cose. Esso giunge così agli antipodi del platonismo, che legittimava il potere attraverso il sapere del bene collettivo. Una volta distrutti i nessi coesivi della società dalla mercificazione capitalistica della vita, è scomparsa l’idea stessa del bene, degradato a utile particolare, e del sapere, degradato a potenza. Ciò che ha la potenza di imporsi, nella produzione, nella distribuzione e nella circolazione, e di fabbricare immagini collettive, diventa perciò stesso credibile. Le informazione stesse che lo sostengono sono fabbricate, mentre la potenza sistemica esclude dalla circolazione informazioni difformi.
La realtà scompare così nel compiuto nichilismo, che la sostituisce con l’effettività sempre flessibile, anche nell’esistenza umana. Postmoderno non è, insomma, che un altro nome per il nichilismo compiuto, che a sua volta non è che un altro nome per il capitalismo assoluto, che non è altro se non una veste della metafisica. La potenza nichilistica del capitalismo, d’altra parte, non ha dovuto superare grosse resistenze, perché le idealità che hanno preceduto il capitalismo assoluto, da quella cristiana a quella marxista, erano trascendenze già in loro stesse potenzialmente nichilistiche. Non è possibile, infatti, credere in un Dio che non impone alcuna lotta concreta contro le ingiustizie del mondo, ed essere poi in grado di lottare contro le ingiustizie che più hanno colonizzato le menti, quelle insite nella potenza del capitale. Non è possibile credere nell’identità tra storia e progresso, identità che è implicita nel marxismo storicamente esistito, e poi essere in grado di contrastare, almeno sul piano intellettuale e morale, il capitalismo assoluto, che è un portato della storia e una sua potenza effettiva.
Attenzione al nichilismo e al nulla quindi.
BReVI AUTORI - volume 3
collana antologica multigenere di racconti brevi
BReVI AUTORI è una collana di libri multigenere, ad ampio spettro letterario. I quasi cento brevi racconti pubblicati in ogni volume sono suddivisi usando il seguente schema ternario:
Fantascienza + Fantasy + Horror
Noir + Drammatico + Psicologico
Rosa + Erotico + Narrativa generale
La brevità va a pari passo con la modernità, basti pensare all'estrema sintesi dei messaggini telefonici o a quelli usati in internet da talune piattaforme sociali per l'interazione tra utenti. La pubblicità stessa ha fatto della brevità la sua arma più vincente, tentando (e spesso riuscendo) in pochi attimi di convincerci, di emozionarci e di farci sognare.
Ma gli estremismi non ci piacciono. Il nostro concetto di brevità è un po' più elastico di un SMS o di un aforisma: è un racconto scritto con cura in appena 2500 battute (sì, spazi inclusi).
A cura di Massimo Baglione.
Contiene opere di: ![]() Giorgio Leone,
Giorgio Leone, ![]() SmilingRedSkeleton,
SmilingRedSkeleton, ![]() Francesco Gallina,
Francesco Gallina, ![]() Laura Traverso,
Laura Traverso, ![]() Umberto Pasqui,
Umberto Pasqui, ![]() Patrizia Benetti, Luca Valmont, Alessandra Leonardi, Mirta D, Pasquale Aversano,
Patrizia Benetti, Luca Valmont, Alessandra Leonardi, Mirta D, Pasquale Aversano, ![]() Gabriella Pison, Alessio Del Debbio,
Gabriella Pison, Alessio Del Debbio, ![]() Alberto Tivoli,
Alberto Tivoli, ![]() Angela Catalini, Marco Vecchi,
Angela Catalini, Marco Vecchi, ![]() Roberta Eman,
Roberta Eman, ![]() Michele Botton,
Michele Botton, ![]() Francesca Paolucci,
Francesca Paolucci, ![]() Enrico Teodorani,
Enrico Teodorani, ![]() Marco Bertoli,
Marco Bertoli, ![]() Fausto Scatoli, Massimo Tivoli,
Fausto Scatoli, Massimo Tivoli, ![]() Laura Usai,
Laura Usai, ![]() Valentina Sfriso, Athos Ceppi, Francesca Santucci,
Valentina Sfriso, Athos Ceppi, Francesca Santucci, ![]() Angela Di Salvo,
Angela Di Salvo, ![]() Antonio Mattera,
Antonio Mattera, ![]() Daniela Zampolli,
Daniela Zampolli, ![]() Annamaria Vernuccio, Giuseppe Patti, Dario Sbroggiò, Angelo Bindi, Giovanni Teresi, Marika Addolorata Carolla, Sonia Barsanti, Francesco Foddis,
Annamaria Vernuccio, Giuseppe Patti, Dario Sbroggiò, Angelo Bindi, Giovanni Teresi, Marika Addolorata Carolla, Sonia Barsanti, Francesco Foddis, ![]() Debora Aprile,
Debora Aprile, ![]() Alessandro Faustini, Martina Del Negro,
Alessandro Faustini, Martina Del Negro, ![]() Anita Veln, Alessandro Beriachetto, Vittorio Del Ponte.
Anita Veln, Alessandro Beriachetto, Vittorio Del Ponte.
Vedi ![]() ANTEPRIMA (215,03 KB scaricato 142 volte).
ANTEPRIMA (215,03 KB scaricato 142 volte).
Biblioteca labirinto
Cinque scaffali di opere concatenate per raccontare libri, biblioteche e personaggi letterari
Riportare la lettura e la biblioteca al centro dell'attenzione dovrebbe essere un dovere di ciascuno di noi. Se in qualche misura ci riesce una raccolta di racconti non si può che gioirne, nella speranza che possa essere contagioso, come deve esserlo tutto ciò che ci spinge a riflettere e a interrogarci sull'essenza del nostro esistere.
A cura di Lorenzo Pompeo e Massimo Baglione.
introduzione del Prof. Gabriele Mazzitelli.
Contiene opere di: ![]() Alberto De Paulis, Monica Porta,
Alberto De Paulis, Monica Porta, ![]() Lorenzo Pompeo,
Lorenzo Pompeo, ![]() Claudio Lei,
Claudio Lei, ![]() Nunzio Campanelli,
Nunzio Campanelli, ![]() Vittoria Tomasi, Cristina Cornelio, Marco Vecchi, Antonella Pighin, Nadia Tibaudo,
Vittoria Tomasi, Cristina Cornelio, Marco Vecchi, Antonella Pighin, Nadia Tibaudo, ![]() Sonia Piras,
Sonia Piras, ![]() Umberto Pasqui,
Umberto Pasqui, ![]() Desirée Ferrarese.
Desirée Ferrarese.
Vedi ![]() ANTEPRIMA (211,75 KB scaricato 224 volte).
ANTEPRIMA (211,75 KB scaricato 224 volte).
Scene da coronavirus
antologia di racconti, testi teatrali brevi e sceneggiature di cortometraggi di carattere umoristico e satirico che raccontano la permanenza in casa legata alla pandemia del Covid-19
A cura di Lorenzo Pompeo e Marco Belocchi.
Contiene opere di: Eliana Farotto, Stefano D'Angelo, Lidia Napoli, ![]() Alessandro Mazzi, Enrico Arlandini,
Alessandro Mazzi, Enrico Arlandini, ![]() Ida Dainese,
Ida Dainese, ![]() Gabriella Pison, Gerardo Porciani, Mariana Ugrica,
Gabriella Pison, Gerardo Porciani, Mariana Ugrica, ![]() Lorenzo Pompeo.
Lorenzo Pompeo.
Vedi ![]() ANTEPRIMA (1,03 MB scaricato 92 volte).
ANTEPRIMA (1,03 MB scaricato 92 volte).
Haiku - il giro del mondo in 17 sillabe
A cura di Lorenzo Pompeo.
Scarica questo testo in formato PDF (589,41 KB) - scaricato 3 volte.
oppure in formato EPUB (230,92 KB) (
GrandPrix d'autunno 2022 - Endecasillabo di un impostore - e le altre poesie
A cura di Massimo Baglione.
Scarica questo testo in formato PDF (525,42 KB) - scaricato 3 volte.
oppure in formato EPUB (391,43 KB) (
Gara d'estate 2022 - Il circo - e gli altri racconti
A cura di Massimo Baglione.
Scarica questo testo in formato PDF (608,16 KB) - scaricato 2 volte.
oppure in formato EPUB (364,92 KB) (